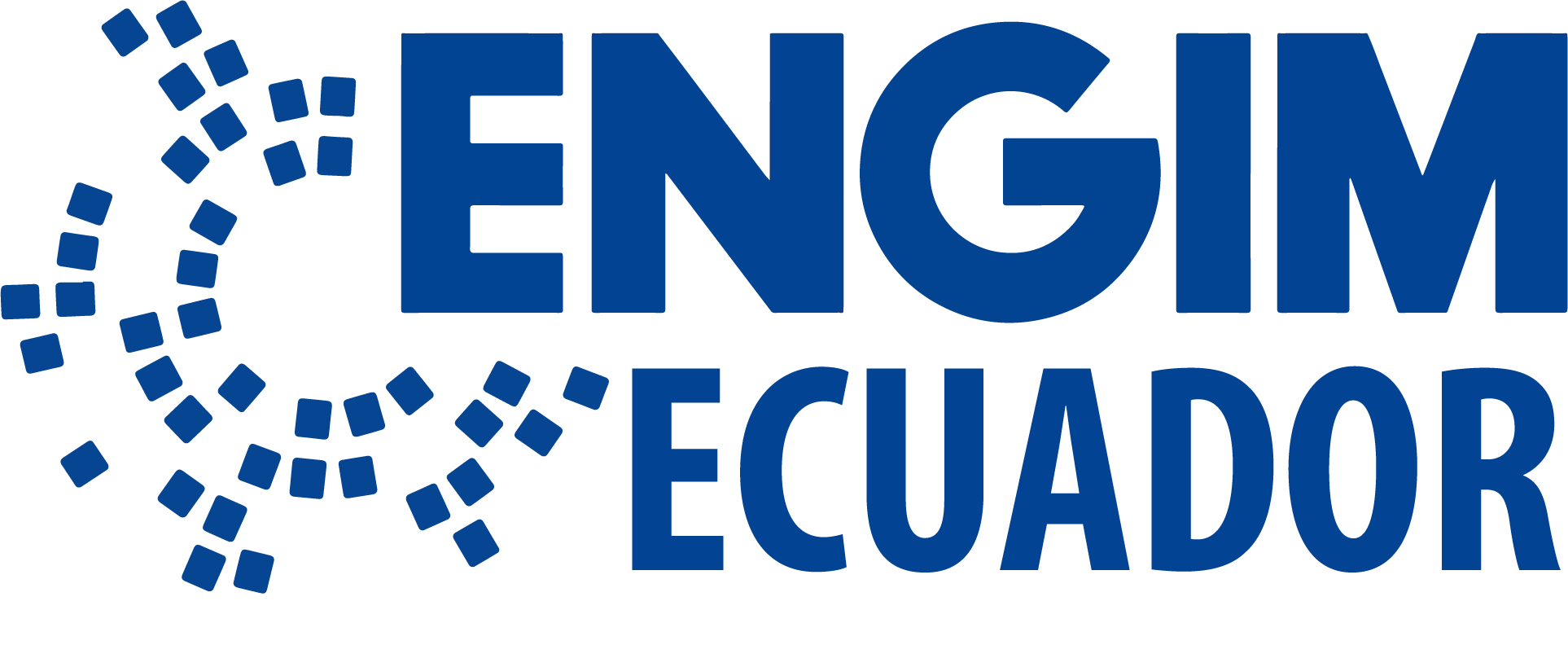di Salvatore Pampinella. Passati i primi mesi di ambientamento e stupore e giunto al giro di boa di questo percorso, mi sto rendendo conto che alcune cose, totalmente estranee alla mia vita prima del Servizio Civile, stanno cominciando a fare parte della mia quotidianità, senza riuscire a capire quando sia avvenuto il passaggio tra stupore ed abitudine.
A partire dal lavoro nelle comunità rurali indigene, in cui i beneficiari non ti trattano più con distacco come un estraneo arrivato nel loro piccolo villaggio da un mondo totalmente lontano.
Dopo mesi passati a lavorare a stretto contatto con la loro vita quotidiana, cominciano a conoscerti, a chiamarti per nome, a domandarti di come va la vita in Ecuador, se ti piace il cibo, se bevi la chicha; ti raccontano di come sia cambiata la vita nella comunità negli anni, delle loro decine di figli, figlie, fratelli e sorelle, dove vivono e che fanno, se studiano, lavorano, delle loro famiglie e anche, purtroppo, di quelli che non ci sono più, morti in incidenti sul lavoro, cadendo in un fossato di ritorno dal monte o per qualche malattia, possibilmente guaribile, che semplicemente identificano come vittime di stregoneria.
Perché sì, accade anche questo, che un giorno andando a lavorare senti di un ragazzo della tua età che vomita e orina sangue da giorni, ma quando proponi ai familiari di accompagnarlo in ospedale ti dicono che non è possibile perché vittima di una maledizione e quindi curabile solo da uno sciamano.
A quel punto ritrovandoti in quella situazione non sai che fare, perché la cultura amazzonica è fatta anche di questo, di rituali e medicine ancestrali, di sciamani e maledizioni di cui possiamo intuire solo il senso più superficiale e ignorare le radici più profonde. Tutto questo fa parte della loro visione del mondo che di certo non si può avere la presunzione di capire a fondo e cambiare. E quindi ti fermi ad osservare, inerme, cercando di apportare l’aiuto che si può senza entrare a gamba tesa nella loro vita e nelle loro tradizioni, ben sapendo che i processi di cambiamento sociale non sono altro che una lunga catena assemblata con anelli di piccoli gesti quotidiani.
Ma ci sono anche tanti momenti di gioia, come quando, arrivando alla comunità di Huamaurco, i piccoli Josè, Carlos, Fatima, Brisa e Jonathan vedendoci cominciano a salutarci e, sorridenti, ci chiamano “Salvador, Flaviola, Andrés”, perché questo ormai è il modo in cui chiamano me, Flavia e Andrea, ovvero i miei due compagni di progetto eugubini.
Chi sono gli eugubini? Gli abitanti di Gubbio! Chi l’avrebbe mai detto che mi sarei ritrovato a lavorare in una comunità di una trentina di case nell’amazzonia ecuadoriana con due eugubini, che fino a prima di partire neanche sapevo dove fosse Gubbio. Quella cittadina sentita nominare solo per Don Matteo, che comunque, mi dicono, ormai si è spostato a Spoleto!
Quindi ormai anche il mio linguaggio sta cambiando e mi ritrovo a parlare con loro una lingua senza senso fatta di un miscuglio di italiano, spagnolo, siciliano ed eugubino, che dall’esterno sembrerebbe incomprensibile, ma che risulta tanto funzionale tra di noi.

Cambia il modo di vestirsi e gli stivali di gomma, semplicemente botas, diventano il prolungamento naturale dei piedi, nonché fedeli compagne nelle lunghe camminate fra i terreni fangosi della selva amazzonica.
I viaggi nel cassone posteriore della camioneta sono quasi diventati la quotidianità, che sia al tepore del crepuscolo, di ritorno da un’escursione, osservando le prime stelle che sorgono, o sulle strade dissestate, sotto la pioggia battente, abbracciato ai tubi dell’acqua per non farli cadere.
In quel cassone dove, lungo la strada per arrivare alle comunità, salgono bambini che ritornano da scuola e donne e uomini di rientro dalla chakra, con il cesto pieno di platani fissato sulla fronte ed il machete in mano. E così a poco a poco la macchina si riempie di donne incinta, bambini, uomini, cani, pale, machete, secchi pieni di chicha, fango, sudore e tante facce stanche ma sorridenti.


Eppure, per quanto possa avere fatto l’abitudine a certe situazioni, ci sono cose che non finiscono mai di stupire, come la quantità infinita di insetti, ragni, piante e frutti che si incontrano in Amazzonia. Camminare nelle comunità in mezzo al fango è sempre una corsa ad ostacoli, con tutti i mingueros che ti osservano ridacchiandoti alle spalle quando esiti tra un ramo che ti ostacola il cammino ed il terreno che ti scivola sotto i piedi. In un attimo finisci nel pantano fino al bacino, con le botas che si riempiono di acqua e fango e tutti a riderti dietro, ma subito pronti a darti una mano per tirarti fuori. Perché nelle comunità il titolo di ingegnere perde di valore quando si tratta di trovare soluzioni a imprevisti che sembrano insormontabili, come tagliare tronchi, spostare rocce e scavare fossati ma che loro, con attrezzi di fortuna e tanta praticità, riescono a risolvere in pochi minuti.


Anche Tena comincia ad apparire sotto un aspetto diverso. Questa cittadina di 30 mila abitanti, nonché il più grande centro abitato nel raggio di 100 chilometri, che all’inizio temevo potesse starmi stretta, adesso appare sotto una luce diversa. Perché ti dà la possibilità di girarla a piedi o in bici, anche di notte, senza particolari preoccupazioni, perché quei quattro soliti locali ormai sono un porto sicuro dove sai che incontrerai qualcuno che conosci con cui poter fare due chiacchiere.
Anche la musica assume un aspetto differente. Ormai so che in macchina, negli autobus, nei negozi, nella sala d’attesa del centro medico per l’ennesimo problema di stomaco o irritazione della pelle, partiranno le note di una cumbia, di un merengue o di una bachata, che ormai come suona una canzone rock l’ho quasi dimenticato. E quel ritmo cadenzato e monotono del reggaeton, da cui scappavo con tutte le mie forze in Italia, qua appare sotto una luce diversa, perché fa parte della cultura nazionalpopolare e tutti l’ascoltano e lo ballano e va bene così, perché in fondo è questa la vita a Tena, nel bene e nel male. Ed ho capito che non ha senso cercare la vita di piazza, i cinema, i concerti rock, i mercatini domenicali dove spulciare fra vinili e camicie estrose. Perché semplicemente qua la vita scorre ad un ritmo diverso ed allora va bene ballare il reggaeton in riva al fiume a maniche corte in pieno gennaio, mettendo da parte le mascherine, il distanziamento sociale e i bollettini di pseudo guerre virologiche e quelle vere a suon di bombe e missili.


Ormai ho preso l’abitudine con il clima e la morfologia dell’Ecuador, che nel giro di tre ore si passa dalle maniche corte e bermuda delle temperature perennemente estive dell’Amazzonia, a passeggiare a 4000 metri nel Paramo andino con sciarpa e due strati di maglioni di alpaca.
E va bene non sapere in quale stagione ci si trova, perché tanto ognuno dice una cosa diversa e non si capisce niente. Siamo in estate o in inverno? Quante stagioni ci sono? Quanto durano? Quando inizia una e finisce l’altra? Che differenza c’è? Ma alla fine cosa cambia realmente? Che importa categorizzare il tempo e quantificare la temperatura? Tanto qua si suda e piove, sempre, e l’umidità e la muffa si attaccano a tutto. Quindi ho deciso di mettere in pausa la mia idea di vita europea, il desiderio del buon cibo italiano ed anche quella voglia di “scrusciu ru mari” che mi porto dentro da siciliano, perché in fondo per il momento è degnamente sostituito dal fragore di un impetuoso temporale equatoriale e dal dolce mormorìo di un fiume che fluisce immerso nella selva amazzonica.