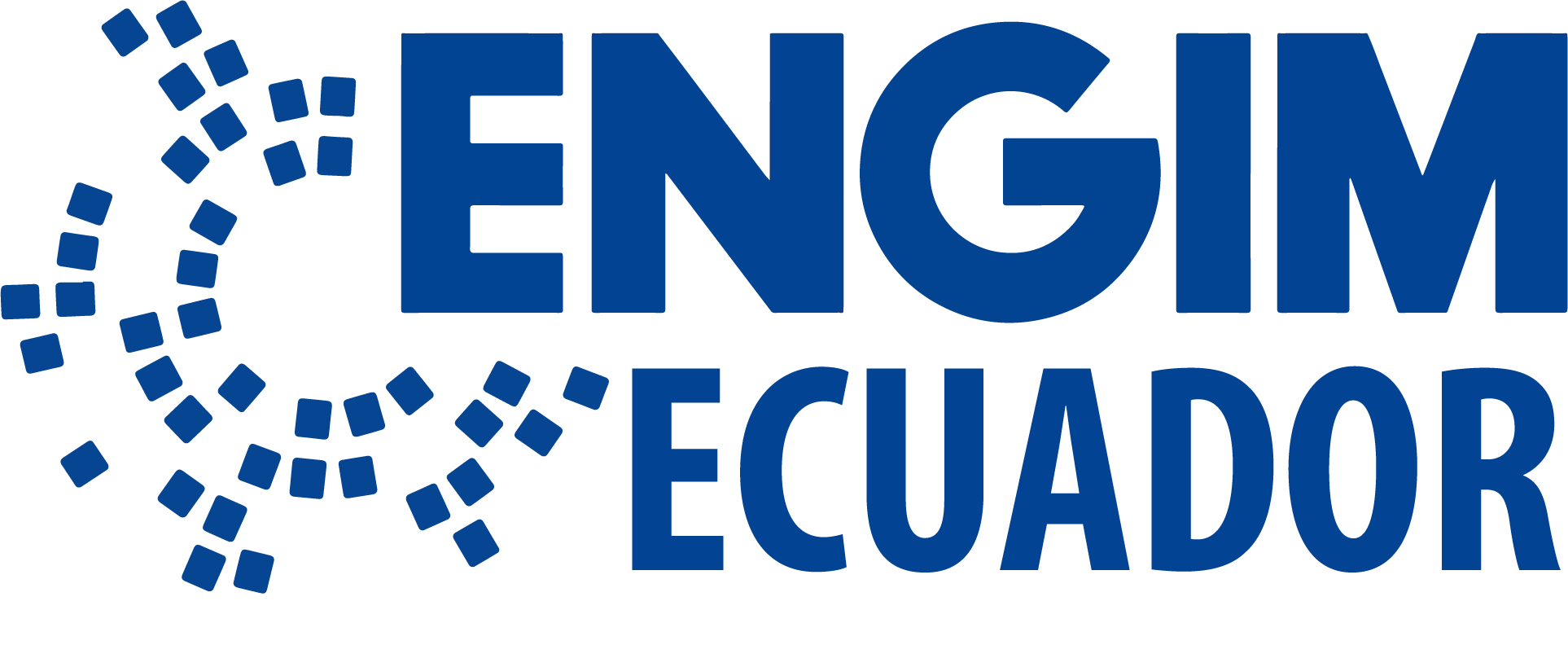di Martina Spinaci – Il posto in cui si trovano è un luogo strano, liminale, al confine tra la città, la selva e il fiume. Per arrivarci bisogna passare il lungofiume piastrellato con le panchine e arrampicarsi su delle scalette. L’ordine urbano aspro e dissestato che regna nelle altre zone di Tena si apre in uno squarcio, il cemento si interrompe e lascia spazio a una strada di terra, si guarda, ed è giù in fondo: un’altra cosa rispetto alle case di sopra, una fitta rete di palafitte incasellata al bordo del fiume. Quando si arriva è una coltre spessa di travi, porte, pareti, pezzi di legno incollati l’uno all’altro, ci sono poche aperture, pochissime finestre, è tutto un intreccio e una confusione. Non si capisce dove finisce una casa e dove inizia l’altra, e se Playita fosse una geometria sarebbe questo: un procedere di anelli consequenziali, una catena. Per sfondare la trama delle case bisogna sapere dov’è un vicoletto stretto scavato tra le case. Varcata la porta, si arriva al centro della comunità, che consiste in un piccolo spiazzo semicircolare, dove i vecchi volontari hanno costruito un tetto di paja toquilla per avere un luogo riparato dalla pioggia dove fare attività con i bambini. Davanti c’è una cancha dove spesso gli uomini si trovano per giocare a ecuavoley, e poi sotto il bordo sfilacciato della vegetazione c’è il fiume.

A Playita andiamo raramente, e quel sottotetto è l’unico spazio che ci è dato conoscere, e su cui possiamo transitare. È lì che proiettiamo i film per i bambini, ed è lì che ci riuniamo con i genitori per informarli sul loro rendimento. A volte Orsiola deve bussare di casa in casa per chiamarli, ma gli adulti spesso non si fanno trovare e sembra quasi che a loro non interessi cosa abbiamo da dire. Come in una specie di relazione tossica tra noi e i beneficiari, non si sa bene se siano più loro ad avere bisogno di noi, o noi di loro. Scendere a Playita è il modo migliore che abbiamo per immergerci nelle dinamiche della comunità, anche se a noi rimangono pressoché oscure. La loro vita più autentica rimane nascosta all’ombra delle loro case, quegli spazi privati che per noi non esistono, quelle stanze di legno semi-vuote in cui vivono tantissime persone insieme, perché noi rimaniamo confinate nello spazio pubblico, la tettoia che è alla luce del sole, dove vieni massacrato dagli isango e dove circolano cani e ratti.
Quando arriviamo, una cosa che cerchiamo costantemente di fare è la difficile ricostruzione del loro albero genealogico. Cerchiamo di districarci tra chi è genitore, zio, parente dei bambini, per sapere chi è il referente a cui dobbiamo rivolgerci. Le relazioni famigliari sono anche quello qualcosa di confuso e inanellato. Un bambino è zio di un altro, una bambina è senza madre, il padre di un’altra ha cambiato compagna e quindi si è trasferito ma ogni tanto ritorna, uno è stato abbandonato e vive con la nonna, ma la nonna è la madre di un altro di loro. Le relazioni hanno qualcosa di libero e meno formale rispetto alle nostre, ma sono anche spesso legate alla violenza e all’alcolismo, il sesso non è qualcosa che si nasconde ai bambini, la maternità viene vissuta senza quel velo di romanticismo e ipocrisia con cui si vive da noi.
Il kichwa, la lingua che parlano, è una lingua agglutinante, che accumula morfemi invece di fletterli, e tutto ciò che noi decliniamo, loro lo ammassano, lo raggruppano nei suffissi appiccicati alle radici. Anche le persone sono così, agglutinate e intrecciate tra loro, con poca speranza di sgrovigliarle per noi che siamo abituati a espressioni facciali meno serrate, una comunicazione più verbosa, una gestualità più pronunciata. Noi che non sappiamo gestire quella distanza invisibile di cui non si parla, ma che tutti silenziosamente avvertono, tra noi, i gringos, e loro, gli indigeni.
Quando i bambini vengono in casa Bonuchelli per fare Apoyo Escolar fanno fatica a separarsi, si cercano spesso tra di loro, stanno lontani dai bambini del barrio o delle altre comunità. Penso a come deve sembrar strano questo spazio ampio e ordinato a loro che sono abituati al groviglio, agli anfratti, alle insenature. Deve sembrare molto esposto questo patio vuoto, queste colonne, questa fila di tavoli e sedie, e quel mistero del secondo piano a cui non possono accedere se non tirando qualche aeroplano di carta che non vola abbastanza in alto, e che a volte rimane incastrato su, tra i cornicioni del palazzo, né al piano di sotto né al piano di sopra.
I loro luoghi preferiti infatti sono i bagni, dove si rinchiudono o si ammirano allo specchio, il pavimento sotto i tavoli, dove si nascondono se non hanno voglia di interagire, il cortile con le altalene. Ma in realtà il loro regno è il giardino. Forse anche perché non glielo permettiamo spesso, se non durante il laboratorio di Medio Ambiente e l’orto scolastico, ma lì c’è qualcosa che scatta. Noi perdiamo un po’ la postura delle educatrici e quel tentativo costante di limitare e ordinare la loro natura pazza e scomposta. Li lasciamo più liberi e loro si lasciano andare: corrono nel fango con le ciabatte di plastica, si arrampicano sugli alberi, sanno maneggiare i machete con tranquillità, ci chiedono cose che i bambini italiani non chiederebbero mai: dei semi da piantare e gli achotillos di cui sono ghiotti, raccolgono granadilla selvatica e ciucciano limoni e frutta silvestre che a volte cospargono di sale e che per noi è quasi immangiabile.
A un certo punto mi rendo conto, forse un po’ troppo tardi, che per fare quello che all’inizio ci sembrava imprescindibile, come creare un legame con loro, fare educazione di genere, laboratori di lettura, matematica e logica, forse serve un linguaggio comune, e per alcuni di loro quel linguaggio è nero e terroso, fatto di semi e frutti.

Fare educazione con loro è una faccenda complicata, e scontrarsi con il sistema educativo ecuadoriano per una persona occidentale è difficile. Nelle scuole rurali, come Huamaurco, esiste una sola maestra e una sola classe, e tutti i bambini della comunità frequentano quella scuola, quando fanno gli esami svolgono tutti lo stesso, indipendentemente dall’età. Nelle scuole urbane i bambini con delle lacune o con problemi di disciplina, come i nostri, vengono lasciati a se stessi.
Per certi aspetti ci mancano le nostre scuole laiche. Non riusciamo ad abituarci a questi libri di testo iper-religiosi, che improntano sin da subito i bambini al senso di colpa cristiano, e che a volte mischiano la scienza con le credenze popolari, parlando in una pagina del sistema solare e nell’altra dei “venti cattivi” che portano morte e malattia.
Per altri versi ci accorgiamo che sono abituati ad un universo simbolico occidentalizzato totalmente distaccato dalla realtà che vivono. A volte ci troviamo a combattere con categorie invasive, presenti tanto nei libri di testo quanto nelle loro teste, pur non avendone mai fatto esperienza diretta. Per esempio, devono saper distinguere l’inverno dalla primavera, l’estate e l’autunno, quando qui non esiste altro che una stagione più secca e una più umida. Per colorare i disegni delle persone ci chiedono il color piel, che è un color rosa pallido; disegnano una casa e ne fanno una di mattoni, con le finestre e il tetto spiovente, come si potrebbe incontrare nei quartieri residenziali di Londra. A Natale splendono per la città luminarie di fiocchi di neve, che simulano nei loro disegni mentre stiamo all’ombra delle palme di chonta e con i soliti 30 gradi. Per tutto l’anno combattiamo per trovare dei materiali scolastici che possano rappresentare il loro mondo, e ci accorgiamo che questa realtà quasi non esiste fuori di qui. Per questo esultiamo quando troviamo per i corsi estivi Ainbo, un film ambientato nell’amazzonia peruviana. E quando proponiamo delle storie cerchiamo di infilarci dentro cose che per loro abbiano senso, le depuriamo di castelli, scarpe di cristallo, e le dotiamo di un universo di botas luccicanti, lanche che scivolano in acqua, guatuse, case di madera aperte, wayusa, abuele sagge, scimmie, fiumi, platani e soprattutto le ambientiamo nel regno magico per eccellenza, la selva.
Difficile ora come ora dire cosa mi porto a casa di questa esperienza con i bambini di Playita e delle altre comunità amazzoniche. Sicuramente qualcosa di scatenato, intricato e pieno di linfa vitale come sono loro, e come un po’ siamo diventate anche noi.