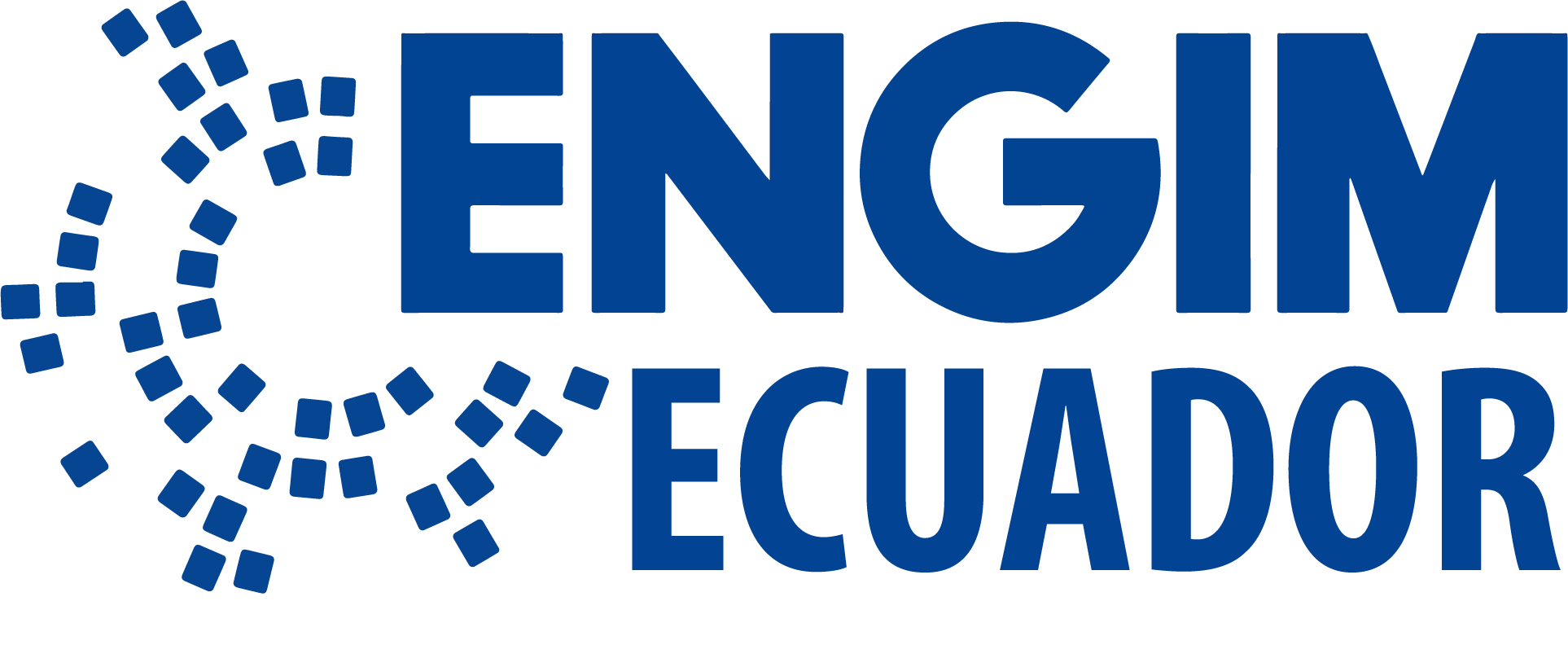Di Annagrazia Graduato. Tutte le preoccupazioni e i volti che popolavano il passato, improvvisamente non esistono più, presa completamente dal momento presente che mi si spalanca davanti, con tutte le diverse e nuove opportunità che questi primi giorni di permanenza in Ecuador mi stanno offrendo. E il presente è fatto di strade trafficate animate da clacson e musica reggae, odori nuovi e non sempre piacevoli che impregnano le narici, giramenti di testa dovuti all’altitudine, volti cotti dal sole della sierra andina.
Ad accoglierci in una delle case destinate ai volontari di Quito è Omar, che per quattro giorni è il nostro cuoco, durante la formazione che svolgiamo insieme agli altri volontari diretti a Tena e a Santo Domingo. Il nostro primo contatto con la cultura ecuadoriana passa per la bocca: il senso del gusto è stimolato e appagato da “quinoa, nachos, zuppe, guacamole”, frutta tropicale di ogni tipo e colore, platano e cioccolato puro al 100% che Omar trita sotto i nostri occhi con un certo orgoglio. Come rimedio per il mal di testa ci offre la “Panela”, nettare grezzo di canna da zucchero al sentore di liquirizia che assaggiamo volentieri per riprendere forza dopo il lungo viaggio.
Il tempo passato insieme in formazione ci unisce ancora di più, lo spazio condiviso è poco, ma la voglia di restare insieme è tanta. Ogni giorno la stanchezza ci vince e ci addormentiamo rapidamente gli uni accanto agli altri, pronti, il giorno seguente, a spalancare di nuovo i nostri occhi curiosi sulle infinite salite della nostra nuova città.

Non credo che dimenticherò facilmente la prima volta che abbiamo attraversato Quito: l’impatto con la città è molto forte, gli autobus che si inerpicano su lunghe pendenze ci portano verso il sud della città e ci fanno sobbalzare, le donne indigene con vestiti tradizionali che vendono ogni tipo di frutta e verdura ai lati della strada ci rivolgono sguardi indagatori e le innumerevoli case colorate che si susseguono senza un apparente ordine ci disorientano.
L’autobus, al mattino presto, corre veloce per le strade di Quito. Quasi non si ferma nemmeno, le porte si aprono e il controllore si affaccia invitando con grida a scendere o a salire “Sigue sigue!”. Dopo che saliamo, molto spesso le porte non si chiudono e l’autobus circola con le porte aperte, da cui salgono al volo anche venditori urlanti che in cambio di un dollaro offrono ogni sorta di dolciumi.
Ogni mattina ci svegliamo alle 5 e mezza per dirigerci a San José de las Monjas, uno dei “barrios” a sud della città. Lo spettacolo che si presenta ai nostri occhi è molto diverso dal centro della città o dal quartiere universitario in cui viviamo: case fatiscenti, fili pendenti e cani randagi ovunque, un insieme di edifici non finiti o abbandonati tradiscono la povertà e la condizione marginale dei suoi abitanti.
Qui si trova la “Escuela Yachay Wasi”, dove dovrò lavorare per un anno con altri due volontari italiani, con cui ho condiviso dieci giorni di formazione e con cui continuerò a condividere una grande casa vicino alla “Universidad Central”. Interessati a diversi aspetti del progetto, insieme riusciamo a mettere in comune le nostre conoscenze per completarci e aiutarci. Chi in cerca di conferme, chi con la voglia di mettersi in gioco e vivere un’esperienza completamente fuori dagli schemi, ci ritroviamo uniti dalle sfide che si presentano fin dai primi giorni. Tra la difficoltà di non capire tutto quello che si dice, ore passate nell’orto, la grande impresa di prendere un autobus che ci porti a casa dopo aver sbagliato infinite volte e la necessità di relativizzare riguardo al concetto di tempo e di assecondare i ritmi latini, cominciamo quasi a sentirci una piccola famiglia.
Anche la Escuela è un piccolo mondo a conduzione familiare: appena entriamo, ci accolgono i “Mashis” (parola kichwa che sta, come poi apprendiamo, per “compañero” e non prettamente “professore”, come pensavamo) Fernando e Laurita, una coppia indigena della Sierra di mezza età che da sempre dedica tutti gli sforzi ad una educazione alternativa, sostenibile e paritaria. Ci invitano ad entrare e ci presentano gli altri mashis, i vicini e altri membri della famiglia che abitano lì vicino o lavorano nella piccola merceria adiacente. Tutti ci fanno sentire il loro appoggio e vicinanza: le titubanze e l’agitazione iniziale svaniscono subito. Parliamo dell’Italia, delle nostre famiglie, di quello che abbiamo lasciato, ma senza rimorso o nostalgia, solo per offrire qualcosa in cambio, come qualche piccola frase in italiano, ai nostri ospiti che ci stanno spalancando un mondo. In effetti, appena mettiamo piede nella piccola scuola, ci sembra immediatamente di essere catapultati in un altro universo: tetti in legno, bambini ovunque e la grande “chacra”, l’orto da cui si può godere di una magnifica panoramica sulle Ande e su tutta la città.
La chacra non è un semplice orto, ma è il simbolo vivo e tangibile della resistenza kichwa per la sovranità alimentare e la perdita dei saperi ancestrali: tutti i mashis de la escuela combattono quotidianamente contro le conseguenze nefaste della modernità e del capitalismo, come la perdita di molte tradizioni e della lingua che le veicola, il kichwa, l’inquinamento, la cattiva alimentazione e le malattie del benessere come il diabete e l’obesità. Sento già che è un ambiente dove mi sento completamente a mio agio, condividendo e lottando per gli stessi valori: spero durante quest’anno di portare anch’io il mio piccolo contributo a questa importante missione.
Ogni mattina, dalle 7 e un quarto, ci ritroviamo per danzare in cortile. Facciamo quello che mashi Nina chiama “riscaldamento”, ma che in realtà come lei stessa ci spiega, “è un modo per costruire i ricordi come bagaglio culturale che i bambini si porteranno dietro tutta la vita”: quando cresceranno avranno sempre in testa la musica che ballavano alla Yachay Wasi, un misto di ritmi indigeni, salsa costeña e musica della Amazonìa.
La musica che ascoltiamo al mattino rispecchia la stessa “mezcla” che da sempre caratterizza la scuola: nelle aule e nei corridoi ci si imbatte in bimbi indigeni della Sierra, afrodiscendenti e mestizos, tutti con diversi accenti e costumi (il lunedì e il venerdì sono i giorni in cui tutti i bambini sono invitati a vestirsi con i propri abiti tradizionali). Sono incaricata di insegnare tutte le materie ad un quinto anno (che corrisponde più o meno ad una nostra quarta elementare): i miei alunni hanno tra i 9 e i 10 anni, e si chiamano Jelly, Jairo, Valentina, Veronica, Carolina, Sayri, Marcos, Sarita e Patricio. Vengono da diversi pueblos della Sierra, dal Cotopaxi, dalla costa o dalla Colombia: c’è posto per tutti alla Yachay Wasi, che fin dall’inizio ha voluto prediligere un modello di educazione interculturale ed inclusivo.
Mi chiedo cosa li abbia portati a Las Mojas e soprattutto in questa scuola così speciale, mi piacerebbe conoscere le loro storie, incontrare le loro famiglie. Per ora mi limito ad osservare e a capire i loro diversi caratteri, cercare di entrare in empatia con ognuno di loro, nonostante la grande diversità e la vivacità di cui danno prova nelle ore di lezione
Non è sempre facile e i primi giorni sono molto duri: come l’esperienza mi insegna, sono quelli in cui i ragazzi provano a “testare” la pazienza dell’insegnante o dell’educatore, vogliono vedere, insomma, quali sono i limiti entro i quali possono agire. È comprensibile che i ragazzi vedano il “mashi” italiano di turno che non sa parlare benissimo spagnolo, come un’occasione di distrazione e distruzione di tutte le regole, ma cerco di rendere le lezioni interessanti, interattive e ludiche: li introduco allo yoga, cerco di stare fuori il più possibile e inserisco qualche momento di gioco per catturare la loro attenzione. D’altronde, non ci sono vere regole alla Yachay Wasi: spesso gli orari non sono rispettati, gli impegni cambiano di ora in ora e i ragazzi vanno da una classe all’altra o si fermano in cortile per saltare alla corda.
Nonostante venga dato loro un codice di comportamento, in realtà, i mashis mirano soprattutto a responsabilizzare e a rendere autonomi gli allievi della scuola. Ho l’impressione che tutti siano molto più maturi e indipendenti di molti ragazzi europei della loro età che ho conosciuto: sanno distinguere le piante commestibili, diserbare a mano, maneggiare coltelli da cucina e incaricarsi delle pulizie giornaliere. Si zappa anche a piedi nudi perché “la terra cura”, così come la pianta d’ortica, che non è vista come urticante e fastidiosa, ma come rimedio e terapia purificatrice.
Durante la classe di cucina, andiamo a raccogliere delle grosse ortiche per condire una tortilla e grande è il mio stupore quando mashi Laurita, per mostrare a tutti i benefici di queste piante, chiede a uno dei bambini di prenderle e strofinarle sulle sue ginocchia.
Serena e impassibile, si alza la lunga gonna fino alle cosce, mentre Alejandro esegue l’ordine per quelli che a me sembrano interminabili minuti. Mi rendo conto solo dopo di aver assistito a qualcosa di molto speciale, sento gli occhi profondi di Laurita su di me, che vogliono testare la mia capacità di andare oltre e di apprendere cose che esulano dai canoni occidentali e moderni. O, semplicemente, li completano: la filosofia della Ishkay Yachay (letteralmente “i due saperi”), la perfetta fusione e compenetrazione tra cultura moderna e saperi ancestrali è l’obiettivo che la scuola Yachay Wasi si propone di rispettare e raggiungere ogni giorno con piccoli passi ed enorme impegno.
Ogni volta che esco dalla scuola, ritorno alla dura realtà del barrio e della capitale. Al supermercato le canzoncine pop di Natale mi ricordano che siamo a dicembre e, dato che il sole è forte e sono sempre a maniche corte fuori, me ne ero quasi dimenticata. I pomeriggi però, sono a volte innaffiati da piogge torrenziali e il caldo lascia il posto ad un clima di montagna. L’aria di Quito sarebbe ancora più fresca se non ci fosse lo smog che talvolta mozza il respiro e brucia gli occhi. I gas di scarico delle auto sono neri, le strade sporche e inquinate. La città si perde a vista d’occhio sulle montagne e sembra quasi che se ne voglia appropriare: le casette di tutti i colori si arrampicano fin sopra i rilievi, inesorabile conseguenza dello sviluppo urbanistico che ha portato la città ad espandersi in maniera forse troppo rapida e asfissiante.
Per fortuna, anche domani salirò a Las Monjas dove potrò respirare meglio a Yachay Wasi, organizzare “talleres” di arte o di cucina naturale, raccogliendo piante nell’orto, insegnare su un tatami, giocare a calcio nella polvere e “descansar” lavorando nella chacra, ascoltando le storie e i consigli di Mashi Laurita e Mashi Fernando, sempre guidati dagli spiriti degli “abuelos”, gli antenati, che prima di andar via ci sussurrano di “pulire la zappa dopo aver lavorato, o gli spiriti non ci daranno tregua, impedendoci di riposare veramente”.