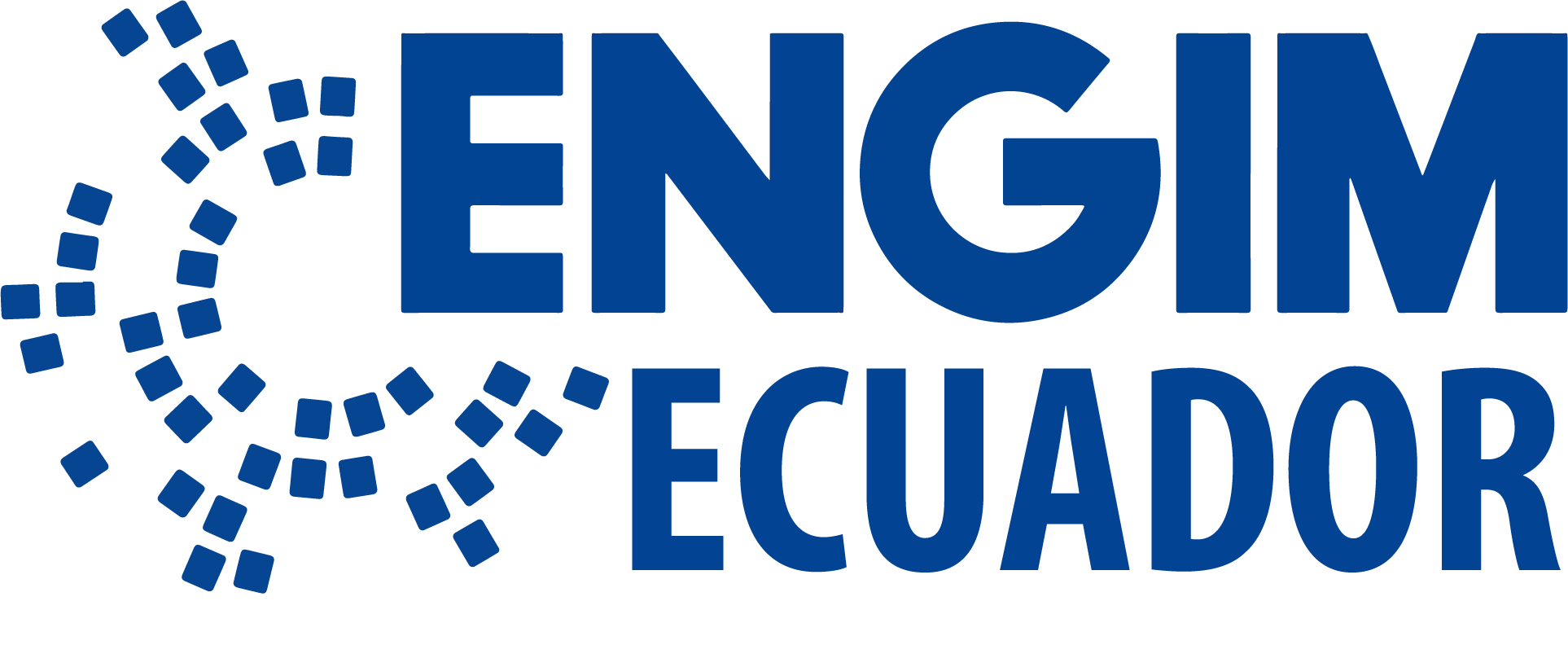di Flavia Ragnacci. In Ecuador ci sono degli alberi che camminano, o così si crede, anche se la scienza non ha ancora trovato una spiegazione plausibile a queste strane radici che li caratterizzano.
Che sia vero oppure no, questa storia mi ha subito affascinato. Il comportamento quasi umano di un albero non è cosa comune, anche se qui la natura offre spesso visioni sorprendenti e, con il tempo, mi sono resa conto che questo è solo uno tra gli alberi
“umani” che si possono incontrare nella foresta.
Senza dubbio è quello che più mi ha intrigato e ha dato vita a pensieri concatenati: più il tempo passava, più mi rendevo conto che i miei pensieri si allineavano sul parallelismo tra questo albero assurdo e la figura del volontario, su di noi.
In Amazzonia i fiumi si muovono e delle zone relativamente secche nel giro di qualche anno possono inondarsi e diventare il nuovo letto del fiume. Gli alberi che camminano sono pronti anche a questo, non si lasciano travolgere, lasciano spazio affinché l’acqua proceda nel suo corso senza farsi tirar via. Allo stesso modo noi non ci imponiamo. Cerchiamo di essere ospiti di questa terra controversa, abbandonando – per quanto possibile – le categorie di giudizio che hanno sempre fatto parte di noi.
Ci assestiamo, cerchiamo un raggio di sole.
Allo stesso modo ci adattiamo. Cose che prima erano impensabili diventano via via più normali. Ciò che ci irritava diventa un problema troppo piccolo per continuare ad infastidirci. La presa in giro di un minguero, che sembrava così inopportuna, diventa un modo per coinvolgerti, per mostrarti simpatia.
Le case mutilate ci sembrano il normale sfondo della nostra vita qua. L’eterno incompiuto. I ferri che spuntano dal cemento cadenzano il nostro passaggio e affermano con prepotenza la voglia di salire ancora più su, ma per ora non si può.

Saliamo nella camioneta alla volta di una delle comunità in cui lavoriamo. Oltre ad un primo tratto di strada asfaltata, improvvisamente si passa a strade dissestate. Gli ammortizzatori ci fanno saltare sui nostri posti, mentre tocchiamo con mano la distanza fisica (e non) tra la città e questi luoghi. Dal finestrino le foglie secche di banano si adagiano sulle reti che delimitano i confini delle proprietà, i ciuffi di paja toquilla tagliati di netto adornano una vista mozzafiato sul Sumaco, che si lascia ammirare solo in certi rari giorni particolarmente tersi.
I bambini ci osservano come fossimo alieni, un po’ sospettosi, ma più incuriositi. Ci guardano ridendo. Mi immagino a volte di guardarci arrivare da fuori. Gli adulti ci trattano con riverenza. Alcuni osservano, aspettano prima di decidere se possono darci fiducia.
Altri ci scrutano diffidenti, con gli occhi arrossati nascosti dietro ad una patina opaca, chiaro segno di un’ebbrezza purtroppo frequente dovuta al trago (bevanda alcolica molto diffusa nelle comunità locali).

La bellezza di questi luoghi contrasta con la miseria quotidiana dei loro abitanti. Ci si abitua anche a questo: alle case di legno che dureranno solo qualche anno; ad associare la presenza di un vetro alla finestra allo status di una famiglia; all’intromissione costante di galline e galli, che alternano perennemente il loro canto al rumore delle nostre pale e delle nostre chiacchiere; alle vecchie signore che, con un po’ di imbarazzo e un sorriso cortese, ti porgono un dito da colorare per poter firmare, lasciando sul foglio la loro impronta: soluzione più che funzionale al non poter scrivere.
In queste giornate incontri anche la morte. La si incontra fin da subito, da quando inizi a capire che nelle comunità sembrano pronti ad accettarla. Quando vedi bambini che si arrampicano su alberi altissimi o che gattonano sulle assi di legno di una casa che sta per essere costruita, capisci che per loro il senso del rischio, della paura e del pericolo sono estremamente diversi dai nostri. Con la stessa rassegnazione vivono ad esempio le malattie, anche le più gravi, additando il mal viento (malocchio, stregoneria) come principale responsabile di questo profondo malessere.
In queste drammatiche occasioni, di nuovo, ti fai albero, alzi una radice, la conficchi più lontano e lasci passare il fiume, non lo affronti, accettando il senso d’impotenza che ti pervade.

La comunità è anche tanto altro. È il piccolo J. che, dopo aver trasportato litri e litri d’acqua fino a casa, risalendo scalette di fango con un’agilità sorprendente per un bambino di 5 anni, si nasconde dietro ad una pianta per farti degli scherzi. È il momento in cui, in un momento di pausa, ti chiedono da dove provieni, che lingua parli, perchè non sei ancora sposata. È l’occasione in cui puoi dire in kichwa le uniche parole che sai: “Ali punzha! Kawsanguichu” (Buongiorno, come stai?) e nonostante non capisci nulla delle loro risposte (e glielo dichiari espressamente) tutti scoppiano in una fragorosa risata e pazientemente cercano di spiegarti parola per parola quello che ti hanno appena detto.
È l’autentico senso di comunità che percepisci, la collaborazione disinteressata e la volontà di mettere a disposizione il proprio tempo per un bene comune.
Delle volte capita di ripartire quasi all’ora del tramonto, che a queste latitudini non tarda ad arrivare. Mentre mettiamo in moto lasciamo alle nostre spalle una lunga scia di persone che, ceste in fronte e banani in spalla, tornano dalle fincas (terreni agricoli) per concludere, col calar del sole, anche questa giornata. La camminata stanca è scandita dai saltelli dei bambini ancora pieni di energia.
Con questa ultima immagine ci avviamo verso la città, più ci avviciniamo più diventano nitidi i rumori del traffico. Ormai anche i clacson, che gli innumerevoli taxi gialli utilizzano per suggerire che sono liberi, sono diventati parte di questa cornice cittadina in cui siamo immersi. I cavi elettrici ammassati su dei grandi pali ci scortano fino a casa.
Sali in camera e ti togli i vestiti, e con loro ti spogli anche di molti agi, schivi ciò che è superfluo. Impari a non lasciarti travolgere dalle impetuose immagini che ti trovi di fronte quasi quotidianamente e, a volte, impari anche a riderci su.
Come l’albero che cammina, fai tesoro della precarietà delle tue radici, delle tue debolezze, e nonostante tutto riesci a muoverti, trovando un nuovo equilibrio proprio per non lasciare che le tue radici decidano per sempre il tuo destino.